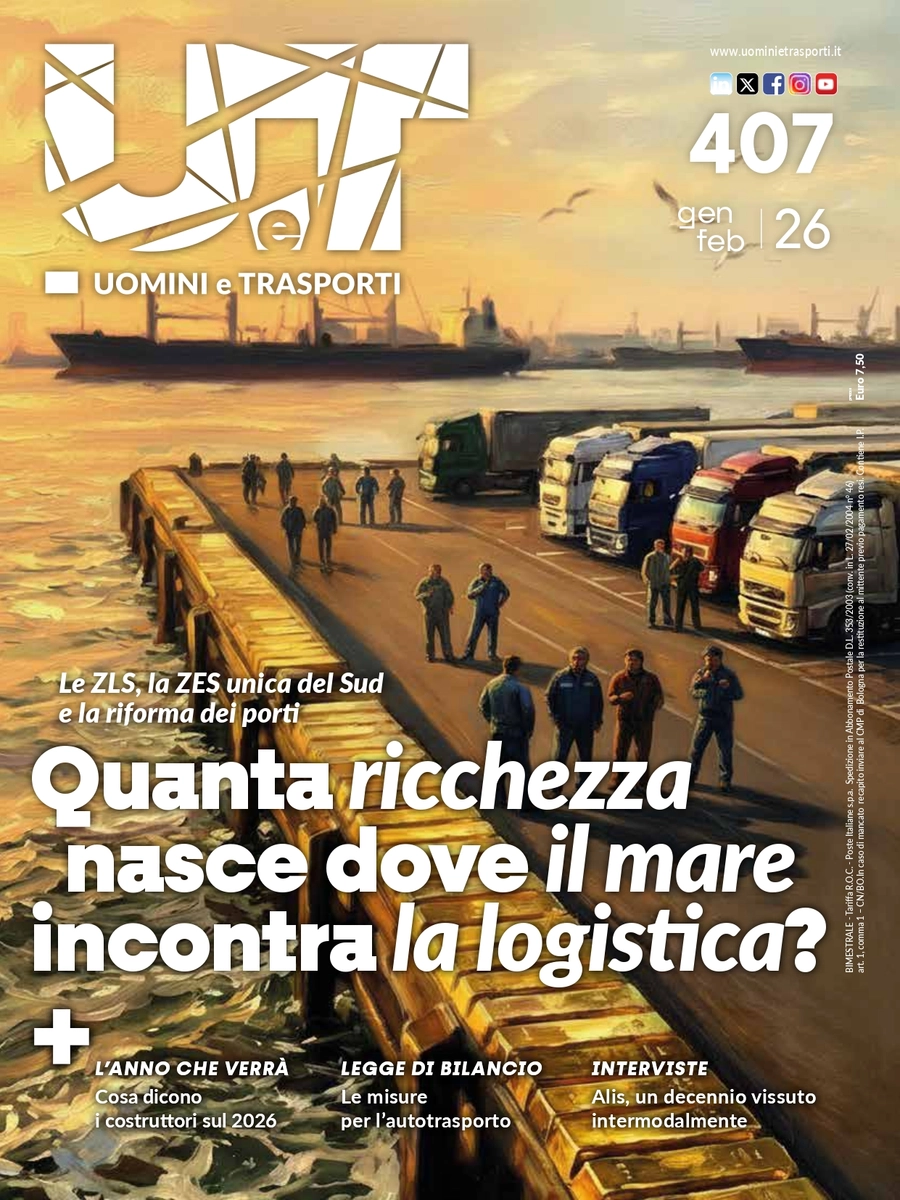Il biometano si conferma una delle leve strategiche della transizione energetica italiana. Ottenuto da biomasse agricole, agroindustriali e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, questo gas rinnovabile può essere impiegato per produrre energia elettrica e termica, per il riscaldamento e come carburante per autotrazione, garantendo emissioni di gas serra nettamente inferiori rispetto ai combustibili fossili.
Ma per raggiungere gli obiettivi del 2030 serve un’ulteriore spinta industriale e politica.
Settore in espansione
Negli ultimi anni la produzione di biometano in Italia ha registrato una crescita significativa, sostenuta dagli incentivi e dagli investimenti previsti dal PNRR. Oggi la capacità produttiva nazionale si attesta intorno ai 570-600 milioni di metri cubi l’anno, con circa 110 impianti allacciati alla rete nazionale del gas. La maggior parte di questi deriva dalla riconversione di vecchi impianti a biogas, alimentati da matrici agricole come scarti e deiezioni animali. La distribuzione geografica riflette la vocazione agricola del Paese: la Pianura Padana concentra la quota maggiore degli impianti, seguita dal Centro Italia e, con ritmi più lenti, dal Sud.
Nonostante i progressi, il divario con gli obiettivi resta ampio: il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) prevede infatti una produzione di 5,7 miliardi di metri cubi di biometano all’anno entro il 2030, dieci volte superiore ai livelli attuali. Secondo alcune stime, con le politiche oggi in vigore l’Italia potrebbe raggiungere i 4,5-5,5 miliardi di metri cubi, ma per colmare il gap serviranno nuove misure e una più rapida realizzazione degli impianti.
Guardando al futuro, la priorità sarà garantire continuità agli incentivi anche dopo il 2026, quando si esauriranno i fondi del PNRR. Con una pianificazione coerente e investimenti mirati, il biometano potrà diventare uno dei pilastri della decarbonizzazione italiana, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 e oltre.
Il trasporto su strada
Un aspetto cruciale ma spesso trascurato della filiera del biometano è la logistica delle biomasse, cioè il trasferimento dei reflui zootecnici e degli scarti agricoli dagli allevamenti agli impianti di digestione anaerobica. Questa fase avviene principalmente con autobotti o cisterne speciali, progettate per garantire sicurezza, igiene e tracciabilità del materiale.
La distanza tra stalla e impianto è un parametro determinante per la sostenibilità economica e ambientale del progetto: oltre i 15-20 km, i costi di trasporto e le emissioni associate rischiano di ridurre la convenienza complessiva. Per questo motivo, la prossimità territoriale è una caratteristica chiave del modello italiano, dove piccoli e medi impianti agricoli sorgono in aree a forte densità zootecnica.
Una logistica efficiente consente non solo di ottimizzare i flussi di biomassa, ma anche di ridurre il traffico pesante e i consumi di carburante, contribuendo alla sostenibilità complessiva della catena del biometano. In questa ottica le cisterne olandesi della D-Tec rappresentano una componente funzionale dell’approvvigionamento e della distribuzione del digestato.


L’esempio di Genco
A Ecomondo era esposta una botte appena entrata nella flotta del Gruppo Genco, che possiede una ventina di trattori alimentati a metano o HVO, una decina di ribaltabili, una decina di cisterne e una ventina di piani mobili.

«Nel 2017 abbiamo acquistato la prima D-Tec», spiega l’AD Isaac Gardella, «e dopo averne noleggiata per due anni una seconda, ne abbiamo comprata un’altra, quella esposta a Ecomondo». «I nostri trasporti riguardano lo scarto successivo alla produzione del biometano, che – diventato digestato – si utilizza poi in agricoltura come fertilizzante naturale, sia allo stato solido che liquido. Si ritira il digestato per poi distribuirlo nei campi: tramite il “ciucciotto” sopra la cisterna viene aspirato dal trattore agricolo e spanduto in campo. A breve, però, per ottemperare alle nuove regole comunitarie, lo scarto sarà più liquido e quindi le cisterne saranno ancora più fondamentali per il suo trasporto. Ma per noi il trasporto riguarda anche la materia prima che concorre alla produzione del biometano: reflui delle cascine, deiezioni di maiali e mucche, oppure anche fanghi di depurazione».
In pratica, la cisterna lavora in modo continuo e a pieno regime. «Riusciamo a utilizzarla a 360 gradi, sia in ingresso che in uscita dagli impianti di lavorazione. E poiché la nostra azienda trasporta rifiuti in generale, con questa cisterna possiamo movimentare qualsiasi tipo di rifiuto – liquido, solido, industriale – compresi quelli chimici non in ADR».
Questo tipo di cisterna offre un trasporto sicuro, a norma di peso e più veloce. «Lavorando con i contoterzisti nei campi, la velocità del trasporto del materiale da spandere è fondamentale, come lo è la maneggevolezza della cisterna nei campi e nelle aie agricole».
Il lavoro di spandimento nei campi, in Lombardia come in altre regioni, è regolamentato: «Non puoi andare nei campi quando vuoi, ci sono finestre precise in alcuni mesi dell’anno, sperando anche che non piova troppo. Addirittura è la Regione a stabilire i periodi in cui è consentito. Per questo avere un mezzo che può trasportare più materiale si ammortizza prima».
«Negli anni», conclude Gardella, «abbiamo adattato anche varie cisterne per fare questi tipi di lavori, ma non ci hanno mai soddisfatto del tutto. Non erano cisterne nate per i rifiuti. Le D-Tec, invece, hanno molte particolarità completamente diverse: sono studiate per questo tipo di attività, con pompe per la pulizia, bocchettoni di scarico più larghi che eliminano meglio i residui, maggiore resistenza rispetto a una cisterna per chimica, più manovrabilità, maggiore portata e un’assistenza capillare garantita dal Gruppo Multitrax».
PNRR e incentivi: la spinta pubblica
Il PNRR ha rappresentato un vero motore per il settore. Il Decreto Ministeriale 2022, legato ai fondi europei, ha finanziato 560 impianti che entreranno in funzione entro il 2026, generando un effetto leva su tutta la filiera industriale. Secondo gli operatori, «il DM 2022 ha creato le condizioni per investimenti importanti e ha dato l’abbrivio per la crescita, anche se i tempi di realizzazione sono molto stretti».
Oltre ai fondi in conto capitale, il sistema italiano prevede incentivi tramite i Certificati di Immissione in Consumo (CIC) e schemi di sostegno per l’uso del biometano nei trasporti, introdotti dal Decreto Interministeriale del 2 marzo 2018. Si tratta di strumenti che favoriscono la redditività degli impianti e incoraggiano accordi di lungo termine tra produttori e grandi consumatori industriali.
L’Europa e la sfida dei gas rinnovabili
A livello europeo, biogas e biometano rappresentano oggi circa il 5% dei consumi complessivi di gas, ma la crescita è costante. Nel 2021 erano oltre 19.000 gli impianti a biogas operativi, di cui 2.000 in Italia, e più di 1.000 quelli a biometano, con Germania, Francia e Danimarca in testa per produzione.
La Germania produce da sola oltre un miliardo di metri cubi di biometano all’anno, seguita dalla Danimarca (380 milioni) e dalla Francia (200 milioni). In Italia la produzione 2020 è stata di circa 100 milioni di metri cubi, ma il potenziale è enorme: la maturità tecnologica del comparto e la disponibilità di biomasse fanno del nostro Paese un laboratorio ideale per l’espansione dei gas rinnovabili.