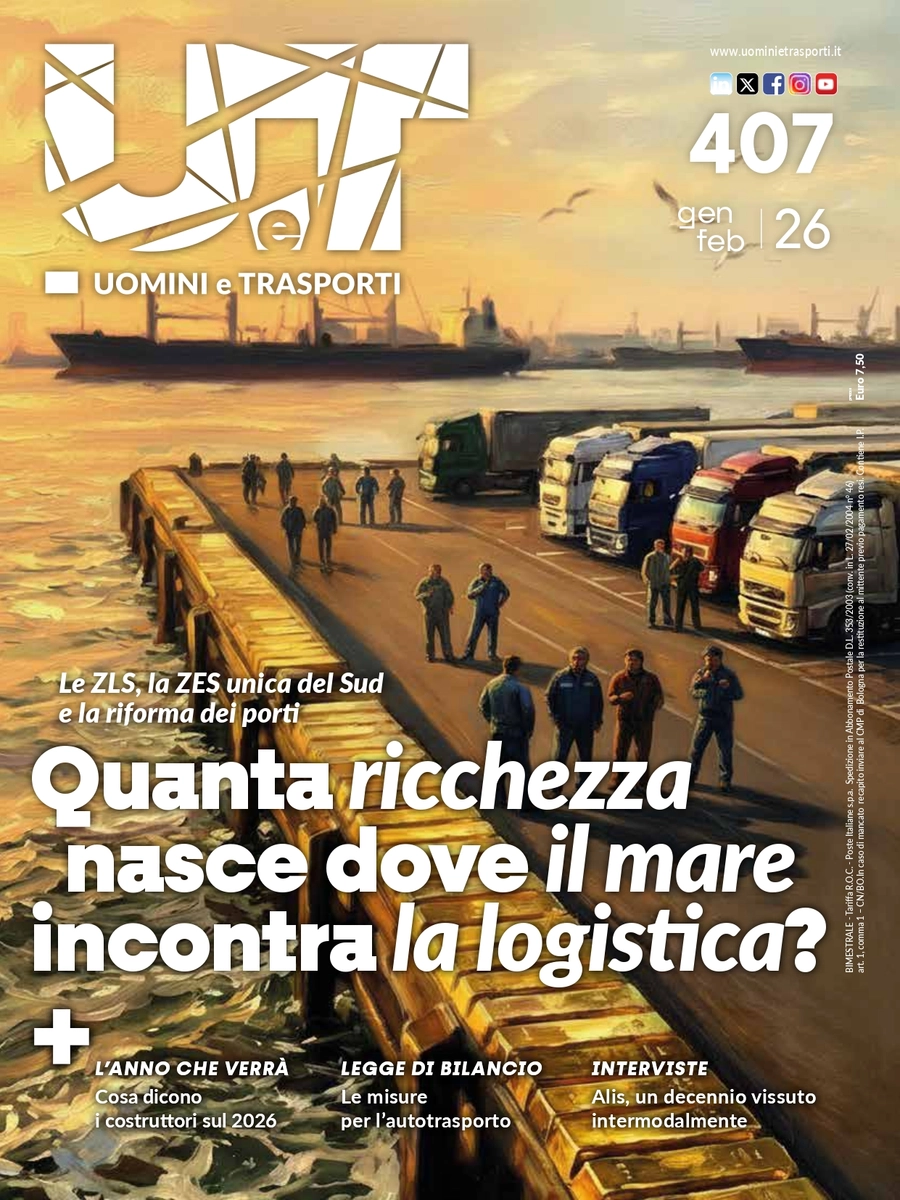Dopo lunghi negoziati, il Consiglio dei ministri degli Affari sociali ha adottato nella notte tra il 23 e il 24 ottobre una direttiva di compromesso sul distacco dei lavoratori. Al riguardo ci sono due notizie, una buona e l’altra meno buona. La prima è che il periodo possibile in cui può svolgersi il distacco si riduce da 24 a 12 mesi, prolungabile di ulteriori 6 soltanto su richiesta del paese ospitante. Dopo questo periodo il lavoratore viene equiparato in tutto e per tutto a quelli del paese in cui avviene il distacco. Ma d’altra parte grandi progressi vengono fatti anche rispetto alla retribuzione, visto che se attualmente ci si limitava a dire che il lavoratore distaccato percepisce la retribuzione minima prevista dai contratti collettivi del paese ospitante, adesso invece si prevede che avrà diritto anche a tutte le indennità e all’eventuale tredicesima. Quindi, le differenze retributive attualmente in essere dovrebbero sparire, rimosse dal principio che a parità di lavoro in uno stesso luogo, scatta anche una pari retribuzione.
Ma attenzione perché tutta questa musica purtroppo non “suona” ancora nel settore dei trasporti, rimasto escluso dall’accordo e al quale quindi continueranno ad applicarsi le attuali norme, in attesa che venga adottato il pacchetto mobilità proposto dalla Commissione europea e peraltro molto criticato dalla parte occidentale dell’Europa. Un’autentica doccia fredda. Cerchiamo di capire come ci si è arrivati.
Innanzi tutto bisogna dire che la trattativa, lunga ed estenuante, ha visto per molti versi la vittoria del presidente francese Emmanuel Macron, che è riuscito a conquistare alla propria causa anche molti paesi dell’Europa orientale. D’altra parte bisogna ricordare che la precedente legislazione in materia risale al 1996, quando cioè l’Unione europea non aveva ancora aperto le porte ai paesi dell’ex blocco sovietico. Ragion per cui, dopo il 2004 e il 2007, anni cioè di 10 nuovi paesi con un tenore di vita e salari decisamente più bassi, avevano messo in crisi i principi su cui si basava. Ma ovviamente i paesi di ultimo ingresso non ne volevano sapere di rivedere la normativa, in quanto garantiva non pochi vantaggi ai propri lavoratori. Alla fine però soltanto Ungheria, Lituania, Lettonia, Lettonia e Polonia hanno rifiutato di sostenere il compromesso, mentre Romania, Bulgaria, Slovacchia e Repubblica Ceca lo hanno accettato, mentre Irlanda, Gran Bretagna e Croazia si sono astenute. Così si è arrivati al testo che segna un grosso passo in avanti, anche se i paesi dell’Est ne hanno preteso un’applicazione differita. La normativa cioè, secondo i calcoli della stampa francese, non entrerà in vigore prima del 2022.
Rispetto ai trasporti su strada, invece, da quanto sembra, la Francia ha dovuto cedere ai ricatti di Madrid, che di fatto si è schierata con i paesi dell’Est. Per la semplice ragione che i trasportatori spagnoli trovano nella Francia una porta di accesso obbligata all’Europa e quindi qui effettuano operazioni di cabotaggio frequenti in competizione con quelli francesi. Ecco perché la Francia si è molto battuta perché non passasse l’esclusione del trasporto dalla normativa sul distacco, con il pretesto che questo lavoro è per sua natura “estremamente mobile”. Ma è anche vero che poi ha ceduto perché comunque ha già adottato delle proprie normative nazionali particolarmente severe, proprio per far fronte alla situazione descritta e per armonizzare il più possibile le condizioni della forza lavoro.
Il compromesso sembra comunque non essere gradito da Karima Delli, presidente della commissione trasporti del Parlamento europeo, la quale ha sottolineato che «non si dovrebbe permettere che le condizioni di lavoro degli autotrasportatori diventino un tabù per l’Europa sociale escludendo questo settore dal campo di applicazione della nuova direttiva. In 15 anni, in Francia sono andati perduti 21.000 posti di lavoro nel settore. Fermare questa emorragia non è più un’opzione, ma una necessità».