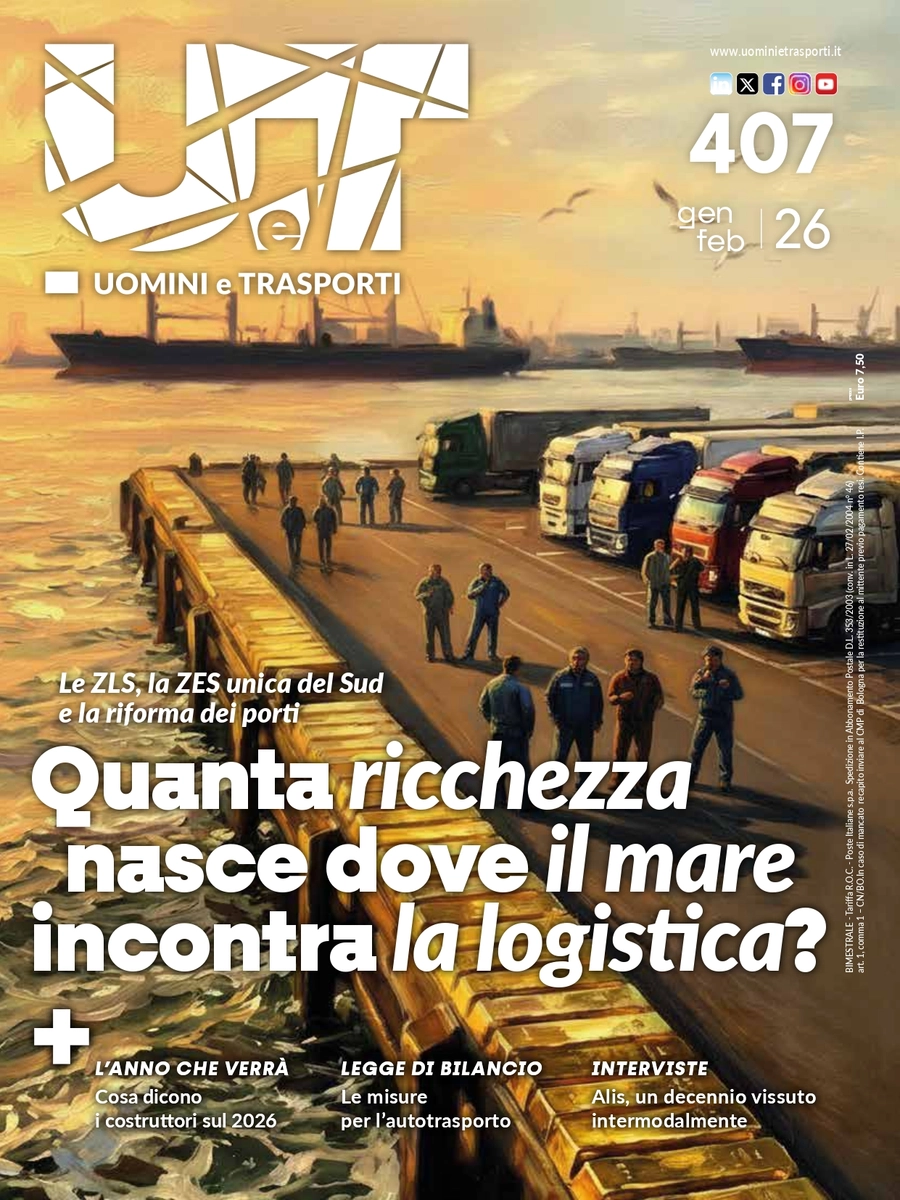Il dibattito sulla norma che introduce il pagamento al vettore per le attese durante le operazioni di carico e scarico non accenna a placarsi. La disposizione, inserita nel Decreto Infrastrutture, era nata con l’intento di tutelare l’autotrasportatore e di ridurre i tempi morti che gravano sulla produttività del settore. Ma, come spesso accade, la sua applicazione pratica ha subito messo in luce numerose zone d’ombra.
A sollevare i primi dubbi era stato l’avvocato Massimo Campailla, che in un’analisi pubblicata da Uomini e Trasporti aveva interpretato la norma come derogabile, in contrasto con la posizione assunta da gran parte delle associazioni dell’autotrasporto, convinte invece del suo carattere imperativo. Ora, a dare nuovo impulso alla discussione, arrivano le prese di posizione ufficiali di Fedespedi e Assiterminal, due voci di primo piano nella filiera logistica nazionale.
Le richieste al Ministero: più chiarezza e meno rigidità
Le due associazioni – rispettivamente la Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e l’Associazione Italiana Terminalisti Portuali – hanno inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e ai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti una richiesta formale di chiarimenti e modifiche alla disciplina.
L’iniziativa, spiegano, nasce dalla necessità di «riportare equilibrio e coerenza operativa» in una normativa che, così com’è, rischia di penalizzare la competitività del sistema logistico anziché migliorarne l’efficienza.
«la disciplina risponde all’esigenza di maggiore efficienza nelle operazioni di carico e scarico, ma, così come modificata, continua a generare incertezza applicativa e non tiene conto della complessità dei nodi logistici, in particolare porti e aeroporti», sottolinea Alessandro Pitto, presidente di Fedespedi.
«Con questa richiesta formale al MIT ribadiamo la necessità di soluzioni normative che si adattino alla realtà effettiva degli operatori, tutelando al contempo la sostenibilità economica e l’operatività quotidiana delle imprese di spedizioni».
Un concetto ribadito anche da Tomaso Cognolato, presidente di Assiterminal, secondo cui l’obiettivo condiviso di rendere più efficiente la catena logistica non può essere perseguito attraverso strumenti rigidi:
«Tutti i soggetti della filiera hanno interesse a migliorare l’efficienza, ma questo non si può raggiungere irrigidendo il sistema. I terminal portuali, come altri nodi logistici e industriali, stanno investendo molto in flessibilità organizzativa: nessuno ha interesse a stressare il sistema».
Tre nodi critici: porti, contratti e franchigia
Nel documento tecnico inviato al MIT, Fedespedi e Assiterminal mettono nero su bianco tre aspetti centrali che necessitano di chiarimenti o correzioni.
1. Porti e aeroporti non sono magazzini ordinari
Le due associazioni contestano l’assimilazione dei porti e degli aeroporti a qualsiasi altro nodo logistico. Si tratta infatti di contesti operativi con dinamiche commerciali e regolatorie particolari, spesso soggetti a vincoli pubblici, procedure doganali, controlli di sicurezza e tempistiche non sempre prevedibili.
Per questo motivo, spiegano, il fenomeno delle attese non può essere affrontato con gli stessi strumenti previsti per i magazzini o gli stabilimenti industriali, ma richiede accordi di programma specifici, promossi dalle autorità competenti. Da qui la richiesta di escludere porti e aeroporti dal campo di applicazione della norma.
2. Il primato del contratto: flessibilità come regola
Altro punto cruciale riguarda la derogabilità della disposizione.
Fedespedi e Assiterminal ribadiscono che solo il contratto tra le parti può tener conto delle innumerevoli variabili operative – tipo di merce, modalità di carico, infrastruttura utilizzata, vincoli doganali, orari dei terminal, ecc. – e che pertanto deve restare lo strumento principale di regolazione dei tempi e delle eventuali indennità.
L’applicazione uniforme di limiti temporali e importi standard, sostengono, sarebbe non solo iniqua, ma anche tecnicamente impraticabile in un sistema logistico eterogeneo come quello italiano.
3. Franchigia: cosa si conta e cosa no
Un ulteriore chiarimento riguarda il cosiddetto periodo di franchigia.
Alcune associazioni dell’autotrasporto hanno interpretato i 90 minuti previsti come comprendenti anche le operazioni materiali di carico e scarico, ma secondo Fedespedi e Assiterminal questa lettura è errata.
Il tempo per le operazioni fisiche, spiegano, va concordato nel contratto, mentre la franchigia deve riferirsi solo al tempo di attesa prima che il vettore possa effettivamente iniziare le operazioni.
Una precisazione tutt’altro che secondaria, visto che da essa dipende la determinazione dei compensi e la stessa applicabilità della norma.
Un confronto ancora aperto
Il confronto sul tema delle attese al carico e scarico si fa quindi sempre più articolato. Da una parte, il mondo dell’autotrasporto rivendica il diritto a un compenso certo per i tempi improduttivi, spesso imputabili a inefficienze dei committenti o dei gestori dei terminal; dall’altra, gli operatori della logistica e dei trasporti internazionali richiamano la necessità di norme flessibili, compatibili con la complessità reale dei flussi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà ora sciogliere i nodi interpretativi, bilanciando esigenze diverse ma interconnesse: tutelare il vettore, garantire la certezza giuridica dei contratti e non compromettere la competitività di una catena logistica che, già oggi, fatica a mantenere ritmi efficienti.
Una partita ancora aperta, insomma, in cui la ricerca di equilibrio tra tutela e praticità rischia di essere il vero banco di prova della nuova disciplina.