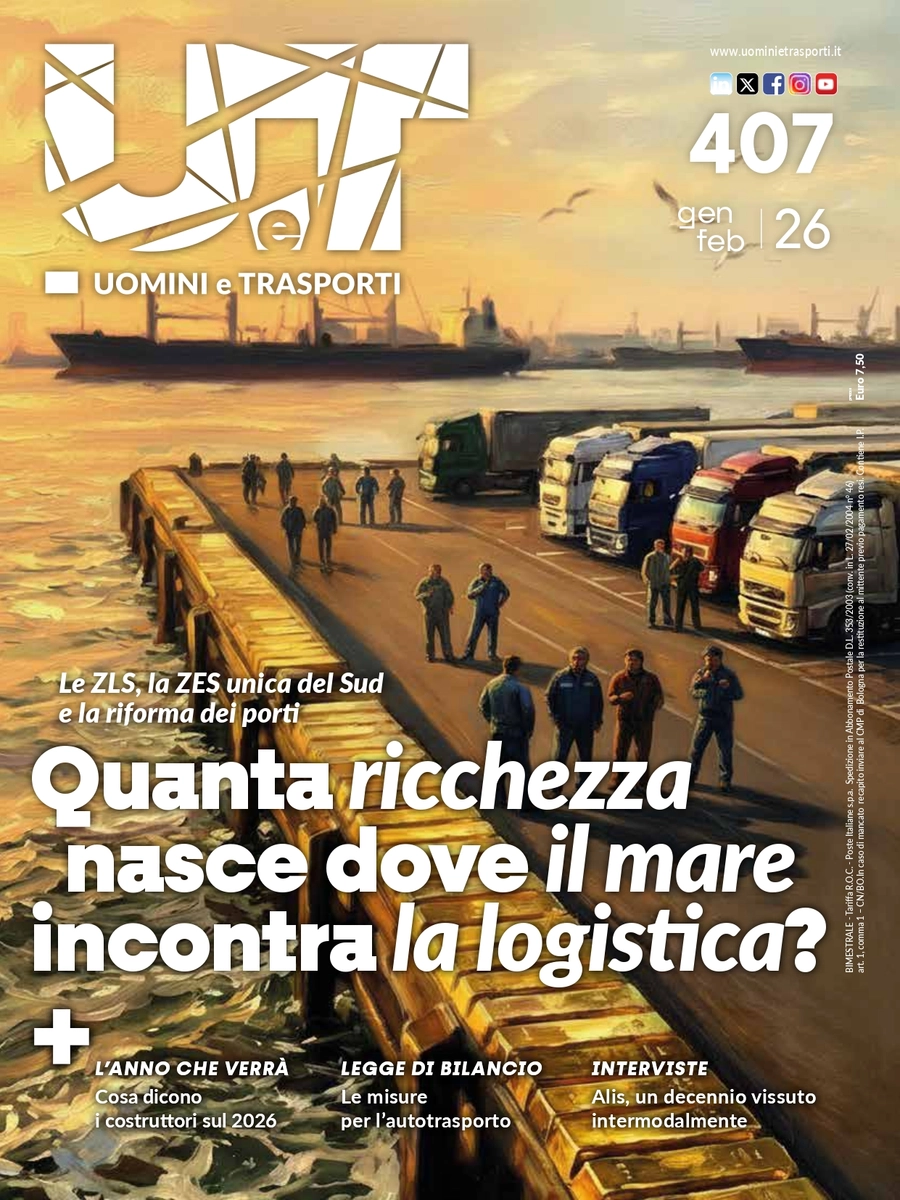«Fare rete»: un’espressione in parte generica, per lo più evocata sotto forma di invito, per stimolare il mettersi insieme, l’aggregarsi, l’unire le forze così da guadagnare maggiore forza. Ma «fare rete» può diventare anche un’espressione tecnica, soprattutto in quei comparti – come il trasporto e la logistica – in cui le attività si susseguono inanellate in modalità e momenti successivi per suggerire l’opportunità di integrarle.
Ma negli ultimi tempi, come ha voluto sottolineare un convegno organizzato lo scorso 16 febbraio a Modena da TForma in collaborazione con Scania per presentare il calendario dei corsi 2016, «fare rete» equivale anche a sfruttare le opportunità offerte da un tipo di contratto, reso interessante da particolari incentivi e articolato almeno in due variabili diverse. Le ha distinte molto nettamente, al convegno, Claudio Villa, presidente del Gruppo Federtrasporti: «C’è la rete soggetto e c’è la rete contratto. Nel primo caso – ha spiegato – la rete diventa un raggruppamento di imprese simile al consorzio, con cui condivide diverse norme del codice civile; nel secondo caso è soltanto un accordo tra imprese, che non assume un’entità economica e patrimoniale autonoma».
Tale distinzione segna una discriminante essenziale. Per una ragione molto semplice: «La rete simile al consorzio – spiega il presidente Federtrasporti – ha soggettività giuridica e quindi deve iscriversi alla camera di commercio, disporre di partita Iva, partita ecc».
Completamente diversa è la seconda tipologia. Villa la liquida come «un’intesa fra imprenditori, che agiscono singolarmente sul mercato e che possono indicare come “capofila” uno di loro in un rapporto contrattuale tra terzi». Ma la soggettività giuridica è esclusa.
Proviamo allora a verificare le conseguenze generate da tale distinguo rispetto all’applicazione di una delle normative più innovative introdotte nel mondo dell’autotrasporto negli ultimi anni: il divieto per il subvettore di delegare a sua volta la vezione. Norma rivoluzionaria in quanto ha innescato un moto aggregativo insperato, maggiore rispetto a quelli indotti da interventi normativi timidi e fuori fuoco. La discriminante secondo Villa è tutta qui: «Nella rete soggetto i trasporti eseguiti dagli associati su ordinativi della stessa rete non sono identificabili come subvezione. Al contrario, nelle reti contratto i rapporti tra imprese aggregate realizzano vere e proprie subvezioni».
Il distinguo tra aggregazioni reali e non
Certo, è un’opinione personale che non trova un chiaro riscontro normativo. Ma esprime comunque un’esigenza sentita da chi, in particolare, nell’associazionismo investe da anni: stabilire una discriminante tra le aggregazioni reali, sostenute cioè dalla comune volontà degli aggregati di crescere e di migliorare le rispettive posizioni sul mercato, e quelle che invece utilizzano presunti strumenti aggregativi soltanto per aggirare una normativa. Insomma, ben venga il contratto di rete se e quando – come recita la legge che lo ha istituito – mira a incrementare «la capacità innovativa e la competitività delle imprese» che ne prendono parte. Occhio però a non farlo diventare una coperta sotto la quale ammantare finalità distanti da quelle richieste dalla legge.
Fare rete “dentro” le associazioni di categoria
Ma il convegno di TForma, reso interessante dagli interventi degli organizzatori (Luca Barassi, Paolo Volta e Francesco Oriolo) e da quello dell’ammnistratore delegato di Italscania, Franco Fenoglio, è stato anche un’occasione per ricordare un’ennesima declinazione dell’espressione «fare rete»: quella riferita al mondo delle associazioni di categoria dell’autotrasporto, presenti numerose a Modena con propri rappresentanti (Amedeo Genedani per Confartigianato Trasporti e Unatras, Cinzia Franchini per CNA-Fita, Claudio Donati per Assotir, Leonardo Lanzi per FAI, Roberto Galanti per FIAP). Una declinazione antica, perché da sempre da tante imprese di autotrasporto si leva l’invito alle associazioni a non disperdere forza in fratture endemiche. Un invito rinnovato dai presenti, amplificato tramite gli interventi della sala e raccolto dai rappresentanti ricordati in modo ondivago. Quasi tutti, infatti, lo hanno sottolineato come un obiettivo e anzi Genedani ha sottolineato come spesso, per raggiungerlo, Unatras – che già di per sé è un raggruppamento unitario – unisca le forze con Anita (associazione confindustriale rappresentativa delle aziende più strutturate) proprio per aumentare il potere contrattuale nei rapporti con il governo.
Gli ha fatto eco Donati sottolineando come un’azione unitaria, di per sé opportuna, trovi ancor più ragion d’essere in una contingenza in cui il ruolo delle associazioni di categoria stenta a esprimersi, anche in conseguenza della modalità “fredda” con cui il governo approccia le trattative con le parti sociali.
Appena fuori dal coro Franchini, la quale ha sottolineato come spesso le differenze di interessi sottese alle aziende rappresentate portino le associazioni ad assumere posizioni distinte. In pratica, pur concordando sull’opportunità di trovare punti unitari di convergenza, Franchini ha rivendicato il diritto di ognuno a conservare una propria diversità, condizione essenziale per non veder appiattire alcune categorie di imprese a vantaggio di altre. Insomma, due posizioni vicine ma diverse: quella dell’unione necessaria e quella – diciamo così – delle divisioni civili. Riusciranno a convivere?