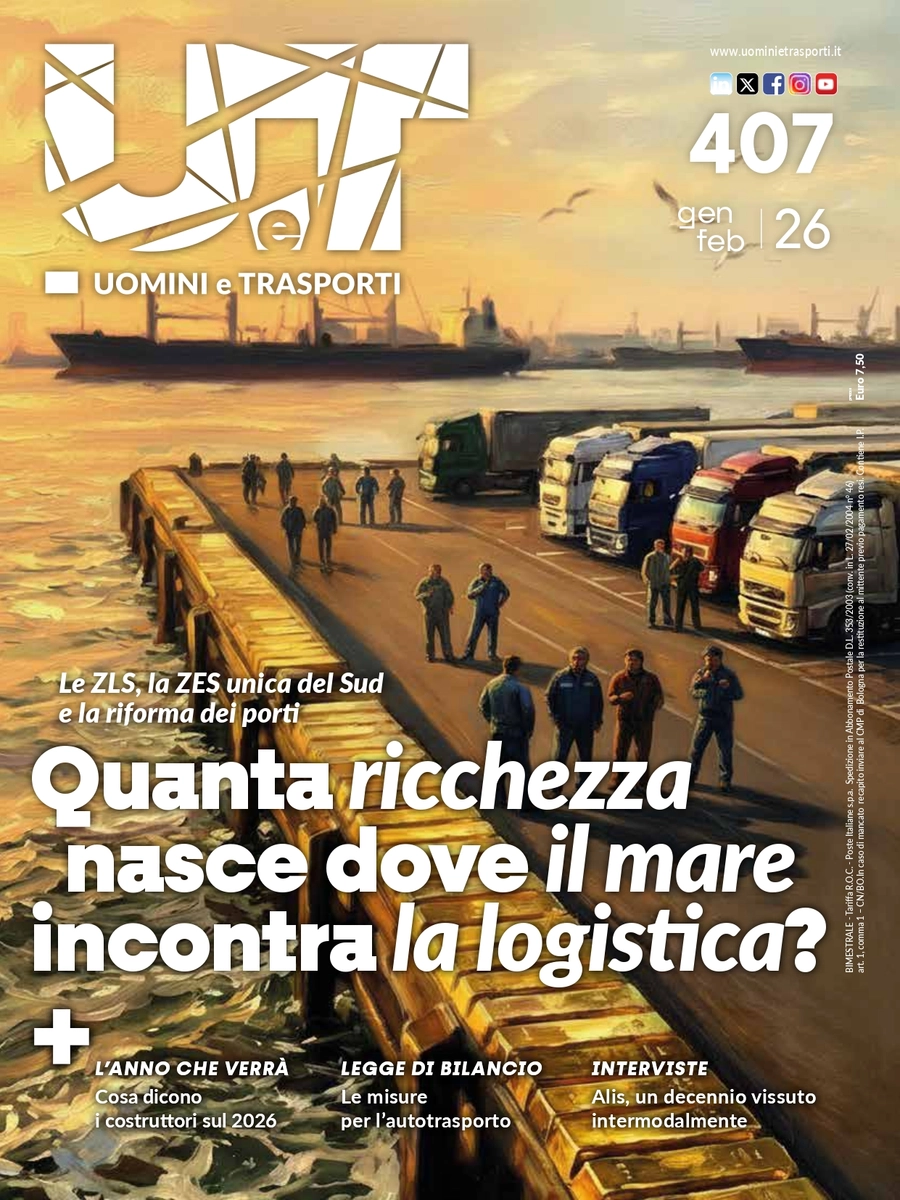L’AFA è finita. Quel servizio di autostrada viaggiante, inaugurato nel 2003, sulla base di accordi bilaterali Italia-Francia, per collegare i 175 chilometri che separano Orbassano da Aiton, ha terminato le corse. Il giorno 21 aprile 2025, la società Autostrada Ferroviaria Alpina, partecipata al 50% ciascuna da Mercitalia Rail (Gruppo FS) e dalla francese Viia (Gruppo SNCF), ha comunicato la sospensione delle attività, puntualizzando che per il momento, non c’è «alcuna prospettiva di ripresa dell’attività».
Una notizia giunta in parte inaspettata, visto che soltanto un paio di settimane prima il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, rispondendo a un’interrogazione in Parlamento da parte dell’onorevole Alessandro Cattaneo (Forza Italia), aveva spiegato che «allo stato attuale (vale a dire il 9 aprile, ndr), il Governo italiano e quello francese stanno valutando la riattivazione di una misura di contribuzione congiunta per ridurre i costi del servizio sulla falsariga della “norma merci” che è stata molto apprezzata dagli operatori». Quindi lo stesso viceministro puntualizzava l’incertezza dell’esito del tentativo, in quanto se anche i due Stati trovassero l’intesa sarebbe stato poi necessario sottoporla «al preliminare vaglio autorizzativo della Commissione europea in merito alla compatibilità con le regole del mercato interno».
I 175 KM COPERTI DALL’AFA

Vita, successi e fine dell’AFA
Ma come si è giunti a tale fine? Per fornire una risposta bisogna riavvolgere il nastro fino al 27 agosto 2023, quando una grande frana fece venire giù un intero pezzo di montagna nel territorio del Comune francese di Saint-Andrè in Savoie causando l’interruzione dell’autostrada A3 che conduce alla galleria del Frejus, della Route Dipartimentale 1006 e della linea ferroviaria che collega Torino con Lione. Oggi, questi blocchi sono stati in parti rimossi, ma l’autostrada viaggiante tra Orbassano e Aiton non è riuscita più a rimettersi in moto. Peccato, dicono in molti, perché questo servizio consentiva ai camion di prendere il treno – anche in modalità accompagnata – e quindi alleggeriva il traffico alpino, consentiva agli autisti di ottimizzare le ore di guida e forniva un’alternativa ai veicoli a 44 tonnellate, esclusi dalla circolazione sul tunnel stradale del Frejus.
La sua utilità peraltro emerge dai numeri. In una ventina di anni di servizio l’AFA si è fatto carico di oltre 500 mila semirimorchi carichi di 1,667 milioni di tonnellate di merci, di categoria ADR e quindi pericolo nel 43% dei casi. In pratica, l’hanno scelta una media di circa 30-35 mila veicoli all’anno con un risparmio in termini di costi sociali di oltre 30 milioni all’anno.
Quanto costa il servizio?
Alle origini dello stop c’è comunque una difficile situazione finanziaria. La società che svolge il servizio, a capitale pubblico italo-francese, è stata messa letteralmente in ginocchio dallo stop successivo alla frana dell’agosto 2023. E oggi non soltanto non ha soldi per continuare a far viaggiare i treni, ma si trova anche con debiti da saldare e personale in cassa integrazione. Per la la precisione i debiti sarebbero intorno ai 4 milioni di euro e, secondo i calcoli effettuati dalla deputata francese, Émilie Bonnivard, che aveva scritto lo scorso 3 febbraio una lettera all’Assemblea Nazionale e sottoposto la questione al vaglio del ministro dei trasporti, Philippe Tabarot, il 1° aprile scorso, sarebbero derivati dal mancato apporto pubblico di 600 mila euro per Paese relativamente al 2023 e di 2,2 milioni di euro (sempre da moltiplicare per due) rispetto al 2024.
Ipotesi di spesa iniziali e quelle riscontrate nella realtà
Le cifre non stupiscono anche perché il servizio non è di per sé economico e non era stato nemmeno concepito come autosufficiente. Italia e Francia, con sufficiente realismo, al momento dell’attivazione della società AFA avevano spaccato i costi in tre, prevedendo che le tariffe pagate dagli autotrasportatori per accedere al servizio avrebbero potuto ripagare circa un terzo degli oneri complessivi. Gli altri due terzi poi se li sarebbero divisi in parti uguali i due Paesi. In realtà, le cose sono andate anche leggermente meglio, nel senso che le entrate sono arrivate a coprire il 40% dei costi. A giustificare la continuazione del servizio, però, era quel risparmio di costi esterni che, come ricordato, è stato quantificato nel complesso in circa 150 milioni di euro a fronte di un esborso pubblico complessivo di 55 milioni di euro. Da questo punto di vista, cioè, la spesa a carico degli Stati è appena un terzo rispetto ai benefici prodotti per la collettività.
Come rendere più sostenibile finanziariamente il servizio
In ogni caso, per cercare ulteriormente di innalzare il risparmio di costi esterni e di spalmare i contributi pubblici su un percorso più ampio, da circa tre anni si era cercato di valutare l’opportunità di allungare il chilometraggio del collegamento, arrivando per lo meno a Lione e da lì considerare se andare anche oltre. Ma queste ipotesi, valutate come possibili fino a due anni fa, sono poi crollate insieme alla frana dell’agosto 2023.
A questo punto, una possibile via di uscita in termini infrastrutturali, potrebbe derivare dal completamento dei lavori del tunnel di base della futura Torino-Lione, opera che dovrebbe essere ultimata tra il 2032 e il 2033 e che potrebbe essere utilizzata anche per riattivare il servizio.
L’interrogazione alla Commissione dell’onorevole Salini
A meno che Bruxelles non si convinca della bontà dell’AFA e non accolga le argomentazioni della deputata francese Bonnivard, che invita a considerare il sostegno pubblico all’autostrada viaggiante come una sorta di ferrobonus.
In ogni caso proprio per stimolare una presa di posizione al riguardo, l’eurodeputato Massimiliano Salini ha presentato un’interrogazione parlamentare alla Commissione Europea per chiedere:
- se l’Europa ritiene utile la riapertura dell’AFA tra Orbassano e Aiton per garantire un servizio di trasporto combinato tra Italia e Francia;
- a che punto sono le trattative tra Commissione e Governi;
- quali iniziative intende promuovere per proteggere l’occupazione di maestranze specializzate, patrimonio del tessuto imprenditoriale locale.
A questo punto si attende una risposta.