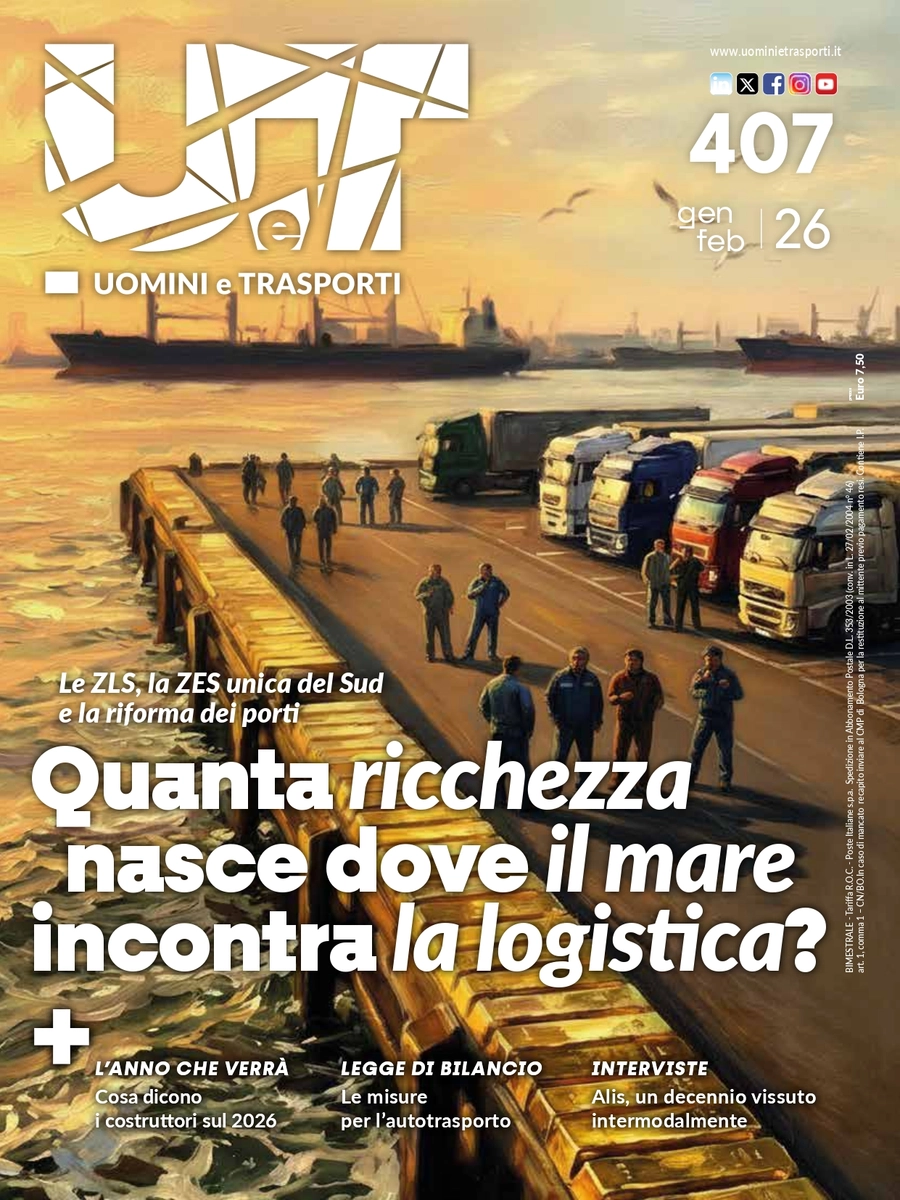Il ritiro a qualsiasi ora del giorno e della notte, niente citofoni, meno consegne andate a vuoto. In Europa i parcel locker sono passati da curiosità urbana a infrastruttura di uso quotidiano. Le reti crescono, gli operatori investono e una parte dell’ultimo miglio si sposta dall’uscio di casa a un punto di ritiro. Il caso più evidente è quello di InPost, che nel 2024 ha superato il miliardo di pacchi consegnati e ha installato decine di migliaia di locker in vari Paesi, con crescite molto forti nel Regno Unito e in Francia.
In Italia il modello aperto sta correndo. Poste Italiane e DHL hanno creato Locker Italia con l’obiettivo di una rete interoperabile e diffusa, capace di arrivare a molte migliaia di armadietti in luoghi strategici. L’idea di fondo è semplice: una rete condivisa riduce duplicazioni, attese e viaggi a vuoto.
Accessibilità fisica e digitale alla rete degli armadietti
La comodità però ha un lato nascosto. Il locker permette al corriere di consolidare molti recapiti in un’unica fermata, tagliando chilometri e fallimenti di consegna. Allo stesso tempo chiede al cittadino un breve spostamento per il ritiro. La differenza la fa il contesto. Nelle aree dense, dove si cammina e si pedala con facilità e il trasporto pubblico funziona, il ritiro può essere una piccola deviazione lungo tragitti già previsti. Nelle zone periurbane o rurali, se per raggiungere il locker si prende l’auto apposta, una parte del beneficio ambientale si perde. La ricerca più recente è chiara: l’effetto positivo per clima e traffico non è automatico. Dipende dall’accessibilità fisica e digitale e dalla collocazione della rete.
Dove installarli, dunque, per massimizzare i vantaggi? La regola d’oro è metterli dove le persone passano comunque. Stazioni ferroviarie, nodi di interscambio, sedi universitarie, uffici pubblici, grandi attrattori di quartiere e negozi di prossimità sono i luoghi ideali. La pianificazione dovrebbe partire da analisi di accessibilità a cinque o dieci minuti a piedi o in bicicletta, dalla densità residenziale e dai flussi giornalieri. Meglio evitare che l’utente debba fermarsi in doppia fila con l’auto. Reti aperte ai diversi corrieri e dimensionate con dati reali, come la rotazione e il riempimento delle celle, riducono il numero di impianti necessari e migliorano l’equità del servizio tra centro e periferia.
Dati confrontabili
Per capire se i locker funzionano davvero per la città e per l’ambiente servono indicatori semplici e confrontabili. Occorre misurare la quantità di anidride carbonica per pacco, considerando sia la tratta del corriere tra deposito e locker sia la tratta dell’utente tra casa e locker e distinguendo le modalità di spostamento. Va monitorata la quota di consegne riuscite al primo tentativo rispetto al domicilio, la percentuale di ritiri a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico, il tasso di riempimento delle celle e l’operatività nel tempo. Conta anche la copertura entro cinque o dieci minuti nei quartieri più fragili, confrontata con la media cittadina. Senza questi dati, i benefici restano sulla carta.
AI e sensori per ottimizzare la rete
La tecnologia può fare la differenza già oggi. L’intelligenza artificiale aiuta a scegliere i siti migliori, non solo a moltiplicare i siti. Grazie a modelli predittivi sulla domanda, sui flussi di mobilità e sugli orari reali, si individuano le posizioni con il maggior impatto positivo e le taglie di cella più adatte. È la stessa logica delle rotte dinamiche dei corrieri: meno chilometri inutili e più consegne efficaci.
I sensori collegati in rete trasformano i locker in macchine che si gestiscono quasi da sole. Segnalano in tempo reale saturazione, guasti, consumi energetici, temperatura e tentativi di manomissione. La manutenzione predittiva riduce i tempi di fermo e aumenta la produttività di ogni postazione. L’esperienza dell’utente diventa più fluida e sicura con codici temporanei, sblocco da vicino tramite telefono e integrazioni standard con più corrieri e con i gestori di edifici pubblici e privati. L’analisi dei flussi consente di definire fasce orarie senza attese e di migliorare i percorsi pedonali e ciclabili attorno agli impianti. Anche la gestione degli spazi di carico e scarico può diventare digitale: con dati condivisi e finestre prenotabili i furgoni smettono di girare a vuoto e di sostare in modo irregolare davanti ai locker. Incrociando dati dei sensori e algoritmi previsionali si possono simulare scenari come picchi stagionali, interruzioni elettriche o cantieri, così da pianificare capacità, energia e turni con anticipo.
Sul fronte normativo l’Europa sta dettando nuove regole. L’AI Act è entrato in vigore nell’estate del 2024 e prevede scadenze progressive nei due anni successivi. Per chi utilizza modelli che incidono su accesso ed equità del servizio diventano centrali trasparenza, gestione del rischio e qualità dei dati. Il Data Act sarà applicabile dal settembre 2025 e favorirà la condivisione dei dati prodotti dai dispositivi connessi lungo tutta la filiera, riducendo i silos proprietari e aumentando l’interoperabilità.
La conclusione è semplice. Non servono locker ovunque. Servono locker nei posti giusti, reti aperte e misurazioni pubbliche, insieme a una vera integrazione con la mobilità dolce e con il trasporto pubblico. L’intelligenza artificiale e l’Internet delle Cose non servono a riempire la città di armadietti, ma a installarne meno e meglio, a farli funzionare sempre e a ridurre traffico ed emissioni. Se amministrazioni e operatori lavorano insieme, con pianificazione basata sui dati, interoperabilità e regole chiare, la prossima consegna riuscita farà bene anche all’aria che respiriamo.