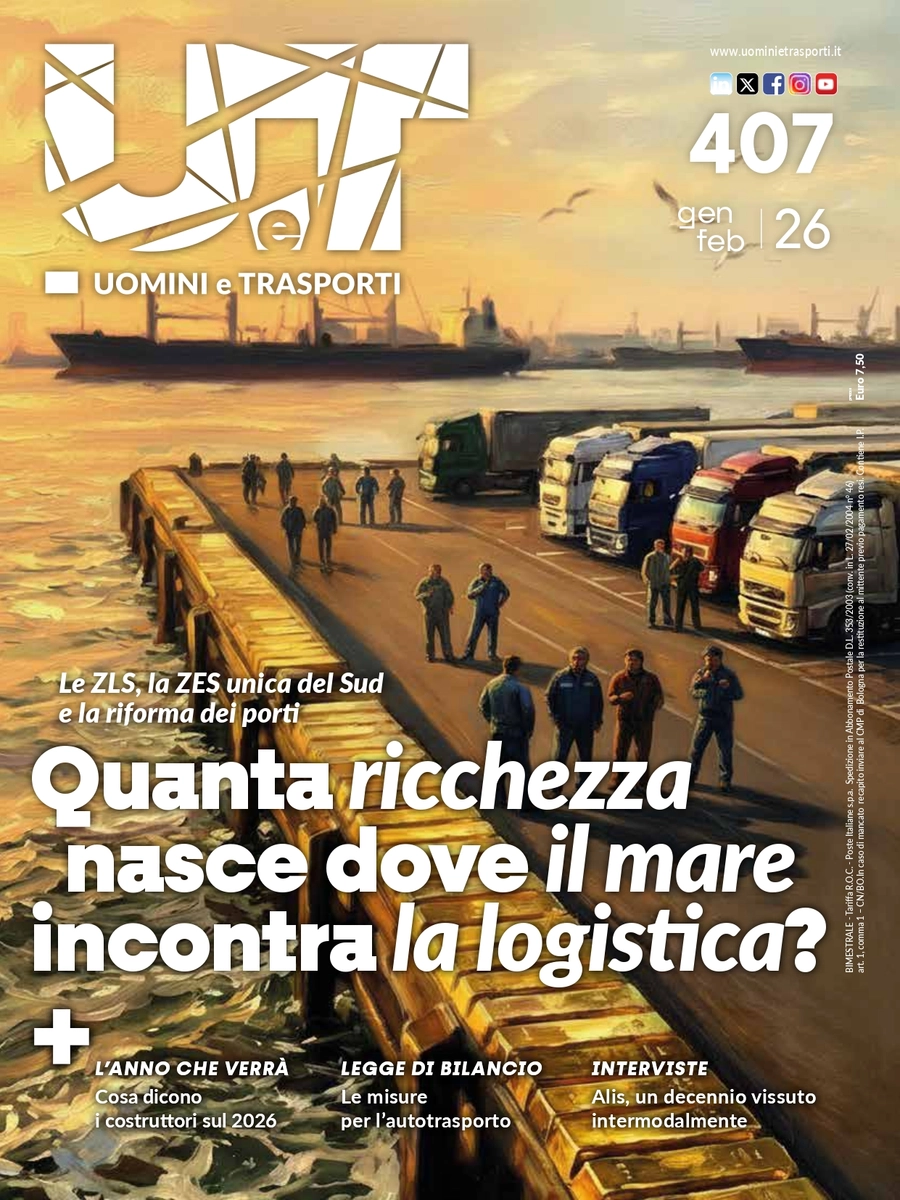Il 22 ottobre 2025 la Commissione Europea ha inserito nel proprio «programma di lavoro per il 2026» l’intenzione di ritirare la proposta di emendamento della Combined Transport Directive, presentata nel novembre 2023 all’interno del pacchetto «Greening Freight Package».
In sostanza: una normativa che avrebbe dovuto aggiornare il quadro europeo per il trasporto combinato (strada + ferrovia + acque interne/marine) non sarà più portata avanti, almeno non nel formato finora proposto.
Perché la normativa era necessaria
La direttiva originaria risale al 1992 (Direttiva 92/106/EEC) e da tempo veniva ritenuta obsoleta per vari motivi: definizioni troppo vaghe, attuazione disomogenea nei Paesi membri, strumenti di supporto poco adeguati.
La proposta attuale, definita nel 2023, puntava a:
- ridefinire il concetto di “trasporto combinato” con criteri più precisi (unità di carico standard, modalità ferroviaria/acquea dominante, legame stradale limitato).
- introdurre obblighi per gli Stati membri di predisporre un quadro nazionale favorevole all’intermodale, trasparenza per i terminal, incentivi per ridurre i costi “porta a porta” di almeno il 10% in 7 anni.
- semplificare la parte amministrativa (digitalizzazione, tracciabilità) e favorire lo spostamento del traffico merci dalla strada alla ferrovia/acque interne, in linea con il European Green Deal. E per tante imprese dell’autotrasporto una cornice aggiornata può equivalere a maggiore certezza, migliore competitività e un incentivo a diversificare il «tutto-strada».
I motivi dello stop: ragioni ufficiali e criticità rilevate dagli operatori
La Commissione ha comunicato che l’iniziativa sarà tolta dall’agenda legislativa, segnalando che non c’era «accordo prevedibile» per portarla avanti nel formato proposto. Inoltre, come evidenziato dagli osservatori, il dossier è stato inserito tra le iniziative «ritirate» senza che iniziasse formalmente l’esame parlamentare. Questa, quindi, è la motivazione ufficiale.
Se però si vanno a sentire gli operatori del settore emergono anche altri fattori e non poche criticità. Tra le diverse possiamo ricordare:
- Scarsa capacità infrastrutturale: la International Union for Road‑Rail Combined Transport (UIRR) ha evidenziato come «l’infrastruttura ferroviaria presenta prestazioni senza precedenti di sottoutilizzo o inefficienza, mancano terminal in molte regioni europee, manca una garanzia minima del servizio».
- Digitalizzazione arretrata e normative vigenti poco efficaci: la direttiva attuale aveva lacune (es. obbligo di documenti cartacei, definizioni datate) che compromettevano la competitività del trasporto combinato.
- Divergenze tra Stati membri e interpretazioni eterogenee: la differenza di trasposizione della direttiva nella prassi nazionale creava incertezza per gli operatori.
- Legame delicato con altri dossier: la proposta di revisione era strettamente connessa ad altri file (per esempio, con le norme sui pesi e dimensioni dei veicoli o sulla regolazione ferroviaria) e la complessità delle negoziazioni ne rendeva incerta la fattibilità.
Pressioni e contesti non favorevoli
L’UIRR, in particolare, ha criticato il fatto che il ritiro sia avvenuto senza consultazione pubblica preventiva e prima che il Parlamento Europeo – il cui relatore in materia è Flavio Tosi – iniziasse il proprio esame.
Non ci sono indicazioni pubbliche chiare di forti lobby contro la revisione, ma è implicito che alcuni Stati membri o operatori stradali avessero riserve sugli obblighi introdotti già rilevate nella consultazione del 2022.
In sintesi: la Commissione ha probabilmente ritenuto che – al momento – il contesto legislativo e politico non offrisse le condizioni per avanzare con una riforma efficace, e che era meglio “tirare il freno” piuttosto che procedere con un testo che rischiava di bloccarsi definitivamente.
Quali erano gli aspetti “inopportuni” della proposta
Anche qui è possibile individuare una serie di più deboli e che non risultavano particolarmente graditi ai più. E tra questi:
- Definizione troppo “rigida” o complessa di trasporto combinato, con criteri che molti operatori avrebbero considerato difficili da soddisfare
- Obbligo per gli Stati membri di ridurre i costi medi di almeno il 10%: un vincolo ambizioso per infrastrutture ancora inadeguate.
- L’esenzione dai divieti di guida notturna/weekend per i veicoli di collegamento stradale prevista nella proposta: un elemento che ha creato forte dibattito.
- Tempi di transizione e attuazione molto estesi e complessi: vista la situazione infrastrutturale variegata in Europa (terminal, digitalizzazione, interoperabilità), molti Stati membri e operatori avrebbero chiesto maggiore gradualità.
- La percezione che la proposta potesse caricare costi e oneri amministrativi aggiuntivi su operatori – specialmente piccoli – del trasporto combinato/intermodale.
Cosa cambia adesso: scenari e incognite
Per il momento il quadro regolamentare vigente rimane quello della direttiva del 1992, senza che la revisione del 2023 venga portata avanti nei tempi previsti.
Operatori, terminalisti, imprese intermodali guardano con preoccupazione: senza un nuovo supporto legislativo la competitività del trasporto combinato rischia di restare compromessa. L’UIRR parla di un «passo indietro» rispetto agli obiettivi del Green Deal.
Gli Stati membri che attendevano la revisione per pianificare politiche nazionali di supporto all’intermodale devono ora riconsiderare la propria strategia.
A questo punto si possono individuare questi quattro possibili scenari futuri:
- Riformulazione della proposta: la Commissione potrebbe tornare sul dossier con un testo rivisto, più semplice e magari legando la revisione ad altri pacchetti normativi (ferrovia, pesi/dimensioni).
- Intervento del Parlamento Europeo o del Consiglio: dato che lo studio parlamentare è stato completato (o quasi) – come segnala la UIRR – l’Europarlamento potrebbe spingere per un proprio testo o per sollecitare la Commissione a riprendere l’iniziativa.
- Rischio di stallo prolungato: senza volontà politica e senza infrastrutture adeguate, il trasporto combinato potrebbe continuare a non godere del supporto normativo sperato, rallentando il cambiamento modale in Europa.
- Maggiore incidenza delle misure nazionali: in assenza di una direttiva UE aggiornata, saranno gli Stati membri a definire politiche proprie (incentivi, sgravi, regolazioni) per sostenere il combinato. Questo però rischia di accentuare la frammentazione normativa tra Paesi.