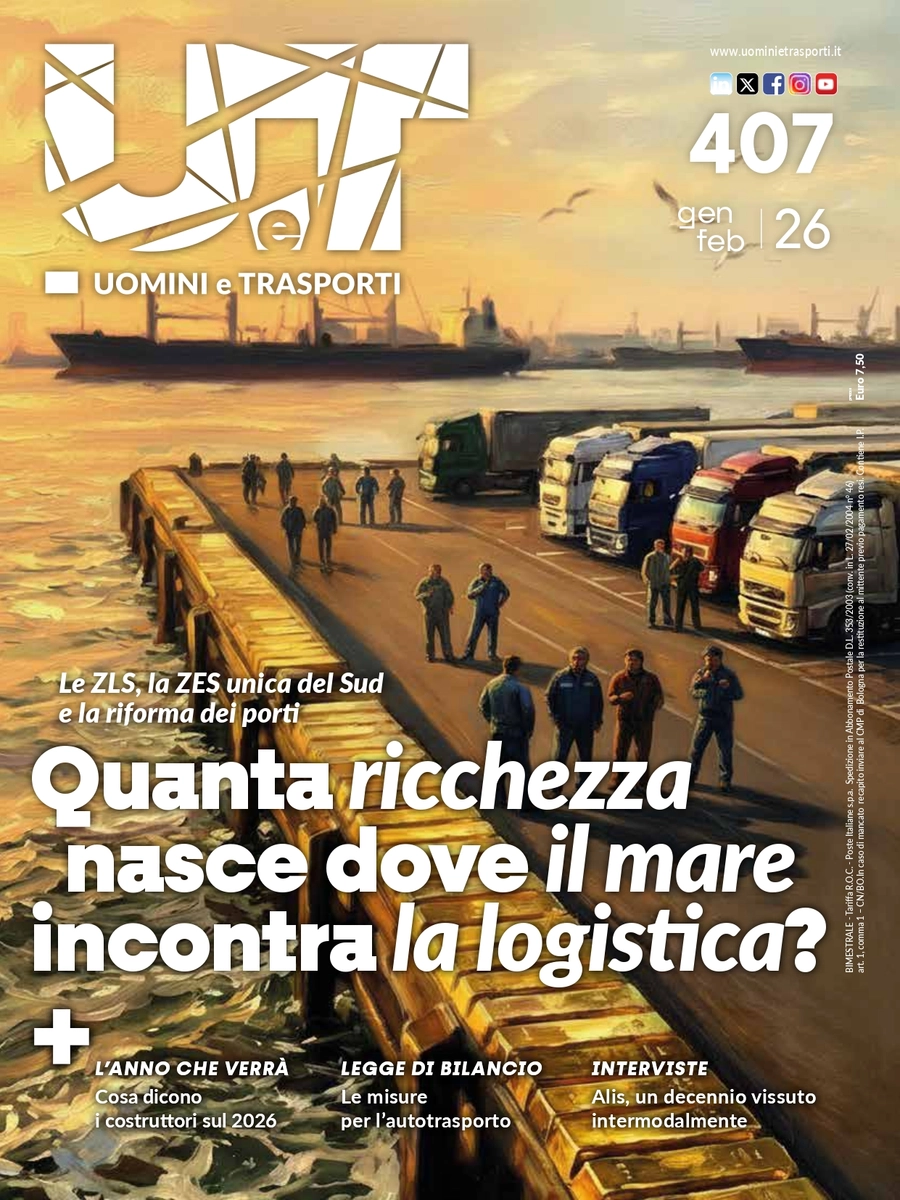Ringrazio Uomini e Trasporti per aver contribuito ad aprire una discussione reale sui problemi dell’autotrasporto italiano. Massimo Marciani, da questo punto di vista, ha sicuramente il merito di aver lanciato il sasso nello stagno, e andrebbe, solo per questo, ringraziato (qui l’articolo di Marciani pubblicato il 26 luglio).
Senza la pretesa di grandi verità, il mio punto di vista, andando per sommi capi, è semplice. L’autotrasporto italiano, per molti decenni ha rappresentato una realtà imprenditoriale a cui la società riconosceva un ruolo e una dignità sociale, nonostante non siano mai mancati i punti di debolezza anche gravi, tra cui il fallimento della gran parte delle esperienze di associazionismo economico nate negli anni ’70 e ’80. A partire dai primi anni duemila, ha iniziato a perdere ruolo e peso, pagandone un prezzo salatissimo anche sul piano squisitamente commerciale.

Le grandi trasformazioni e il deficit di cultura imprenditoriale
Tutto ciò è successo per due ragioni principali: innanzitutto, per non aver compreso per tempo gli effetti delle grandi trasformazioni economiche, tra cui il processo di concentrazione dei grandi operatori, con lo sviluppo dell’attività logistica, corollario quasi automatico della globalizzazione, che ha visto molti innamoramenti – con pochissimi approcci critici -negli ultimi venti anni (Assotir, un po’ meno di altri, visto che è nata proprio come risposta ai danni che la liberalizzazione selvaggia era in procinto di provocare in un settore composto essenzialmente di piccole e medie imprese).
L’altro motivo è rappresentato proprio dal deficit di cultura imprenditoriale – che vale anche per le associazioni e, non solo per l’autotrasporto- che ha impedito di cogliere le implicazioni, in termini di trasformazioni necessarie per il nostro mondo, dal tramonto del “piccolo è bello”, alla necessità, specie quando si è troppo piccoli, di fare squadra, alla consapevolezza che la frammentazione fa il gioco del committente e non va incentivata.
Questi elementi possono aiutare a spiegare la drammatica situazione odierna, nella quale l’1% degli operatori della logistica – iscritti quasi tutti all’Albo degli Autotrasportatori, quindi, a tutti gli effetti, vettori, nonostante risultino praticamente “senza camion”, perché con i loro veicoli non arrivano a coprire il10% del loro fatturato – gestiscono il 50% del mercato (60 miliardi di euro). Di questi, almeno il 90% (oltre 50 miliardi) è dato in subvezione. E non è detto che i passaggi si fermino lì.
Divaricazione estrema tra titolare del contratto e trasportatori
Il salto di qualità, per così dire, degli ultimi 15 anni, è la divaricazione estrema che si è attuata tra il titolare (spesso multinazionali, con un numero di camion minimale) del contratto di trasporto, del valore di milioni di euro e i suoi fornitori, cioè quei trasportatori che effettivamente eseguono i trasporti. Tutte le enormi operazioni di concentrazione aziendale hanno escluso l’autotrasporto, attività “esternalizzata” per eccellenza, semplicemente perché scarsamente remunerativa. Anzi, eliminando gli oneri e i rischi di un’impresa di trasporto (camion e personale, pagamenti, etc), l’obiettivo dei big si riduce alla ricerca del prezzo più basso, nella certezza di trovare comunque qualcuno disponibile – dopo aver lasciato una congrua provvigione – a effettuare il trasporto per loro conto.
Proporzionalità tra veicoli, addetti e subvezione
Dire come si esce da questa situazione non è facile. Per noi, la priorità da cui partire è chiara: l’introduzione, come requisito per fare la professione di trasportatore, anche in Italia, del principio di “proporzionalità” nel numero di veicoli e di addetti, rispetto al fatturato. In Francia un trasportatore deve sviluppare almeno l’85% del fatturato con veicoli e personale proprio, e può dare in subvezione al massimo il 15%. A questo, oltre tutto, ci obbliga – una volta tanto, fortunatamente – l’Europa. Ciò nonostante, per quattro anni si è fatto di tutto per impedire che questa norma fosse recepita.
Chi si è opposto? Committenza, Politica e Associazioni dell’autotrasporto.
La rappresentanza e il conflitto d’interesse
E qui arriviamo al tema della rappresentanza che, a mio parere, non ha come difetto principale la troppa frammentazione (che pure esiste), ma l’enorme conflitto di interessi al suo interno, perché nello stesso tavolo c’è, sia chi, come noi, rappresenta i trasportatori, e chi rappresenta quella committenza che, travestita da primo vettore, campa sulle spalle dei secondi o terzi vettori.
Ecco perché, con il recepimento del regolamento Ue 1055/2020 almeno due enormi problemi (intermediazione e rappresentanza dell’autotrasporto) possono trovare una risposta chiara e utile per ridare una prospettiva imprenditoriale, oggi del tutto assente, a questo settore e, anche, a caduta, un ridisegno della rappresentanza dell’autotrasporto, in un quadro di interessi non più inconciliabili. Forse, a quel punto, anche i percorsi unitari potrebbero essere più agevoli.
Il rischio di diventare esecutori di ordini
A giugno scorso – con due anni di ritardo – e dopo aver fatto scadere la delega precedente, il Governo è stato reintegrato dal Parlamento (legge di delegazione 2024) nella delega per legiferare su questa specifica materia, e ci aspettiamo che adesso faccia il suo dovere. Gli altri, non dico le controparti, ma almeno chi dice di rappresentare i trasportatori, dovrebbero essere espliciti. E anche i trasportatori non farebbero male a darsi una svegliata. Altrimenti, il rischio che le cose procedano nella direzione su cui sono già ampiamente avviate, cioè verso il declassamento del trasportatore da imprenditore a mero esecutore di ordini, è più che elevato.